|
Impariamo
a
digiunare
Fa' digiunare il nostro cuore:
che sappia rinunciare a tutto quello che l'allontana dal tuo amore,
Signore,
e che si unisca a te più esclusivamente e più sinceramente.
Fa' digiunare il nostro orgoglio,
tutte le nostre pretese, le nostre rivendicazioni, rendendoci più umili
e infondendo in noi come unica ambizione quella di servirti,
Fa' digiunare le nostre passioni, la nostra fame di piacere,
la nostra sete di ricchezza, il possesso avido e l'azione violenta;
che nostro solo desiderio sia di piacerti in tutto.
- La penitenza coinvolge la
persona nella sua totalità di corpo e di spirito: l'uomo ha un corpo
bisognoso di cibo e di riposo; si appropria e si nutre delle cose ma è anche
capace di solidarietà e di condivisione. Digiuno e astinenza non sono forme
di disprezzo del corpo, ma strumenti per rinvigorire lo spirito.

- E' importante
sottolineare che la prassi penitenziale della Chiesa, nelle sua varie forme,
raggiunge il suo vertice nel sacramento dalla Penitenza e della
Riconciliazione. Il cammino di conversione trova il suo significato nella
salvezza donata in Cristo morto e risorto; quindi, è nell'inserimento nel
mistero di Cristo pasquale, mediante la fede e i sacramenti, che tutti i
gesti, grandi e piccoli, di penitenza e di digiuno e tutte le opere di
carità acquistano significato e forza di salvezza.
- La Chiesa stabilisce
alcuni tempi e giorni comuni in cui digiunare per evidenziare il carattere
comunitario della penitenza: è quindi l'intera comunità ecclesiale ad essere
comunità penitente. Questi tempi e giorni vengono scelti tra quelli che, nel
corso dell'anno liturgico, sono più vicini al mistero pasquale di Cristo o
vengono richiesti da particolari bisogni della comunità ecclesiale.
- Fin dai primi secoli il
digiuno pasquale si osserva il Venerdì santo come segno della partecipazione
comunitaria alla morte del Signore; così si inizia la Quaresima, tempo
privilegiato per la penitenza in preparazione alla Pasqua, con il digiuno
del mercoledì delle Ceneri per invocare il perdono dei peccati e manifestare
la volontà di conversione.
- Il problema del digiuno e
dell'astinenza si collega con Il problema delta giustizia e della
condivisione dei beni della terra: anche la singola persona è sollecitata ad
assumere uno stile di vita improntato ad una maggiore sobrietà, capace di
attivare gesti di carità e condivisione. Il grido dei poveri esige che i
gesti religiosi del digiuno e dell'astinenza diventino Il segno dl un più
ampio impegno di giustizia e di solidarietà: <<lontano da me il frastuono
dei tuoi canti: il suono delle tue arpe non posso sentirlo! Piuttosto scorra
come acqua il diritto e la giustizia come un torrente perenne>> (Am
5,23-24). In questo senso Il digiuno del cristiani deve diventare un segno
concreto di comunione con chi soffre la fame, e una forma di condivisione e
di aiuto con chi si sforza di costruire una vita sociale pù giusta e umana.
<<In senso lato, il digiuno è
limitazione volontaria dei bisogni al fine di liberare il desiderio più profondo che ci abita, un
desiderio che, in modo inscindibile, vuole celebrare Dio e servire il prossimo. Un simile cammino ha senso
solo se legato
 al "digiuno spirituale". Bisogna imparare a digiunare dall'amore per il potere e
dalla vanagloria, a non alimentare il nostro amor proprio; a digiunare dai ragionamenti inutili e dalle
parole vane, da ogni uso della lingua che faccia di quest'ultima strumento di potere o di profitto; dalla
maldicenza, dalla parola di menzogna, che a volte è capace di uccidere. E poi necessario adattare il
digiuno alle forma odierne della civiltà. Fin dai primi secoli del Cristianesimo il digiuno trova
la sua realizzazione nella condivisione. L'esperienza della fame, per quanto limitata, ci fa comprendere la
fame degli uomini: che testimonianza potrebbe recare la Quaresima nei nostri Paesi occidentali, nei
quali molti mangiano fin troppo (anche se alcuni non abbastanza)! Il problema si pone oggi su
scala planetaria. Giovanni Crisostomo ricordava che "la bontà, la compassione, la misericordia e
l'amore esprimono contemporaneamente sia la natura di Dio che il suo operare", e che il povero e un
altro Cristo. Possa un digiuno, condotto con intelligenza, liberare le nostre intelligenze dagli
idoli dell’economia>>. al "digiuno spirituale". Bisogna imparare a digiunare dall'amore per il potere e
dalla vanagloria, a non alimentare il nostro amor proprio; a digiunare dai ragionamenti inutili e dalle
parole vane, da ogni uso della lingua che faccia di quest'ultima strumento di potere o di profitto; dalla
maldicenza, dalla parola di menzogna, che a volte è capace di uccidere. E poi necessario adattare il
digiuno alle forma odierne della civiltà. Fin dai primi secoli del Cristianesimo il digiuno trova
la sua realizzazione nella condivisione. L'esperienza della fame, per quanto limitata, ci fa comprendere la
fame degli uomini: che testimonianza potrebbe recare la Quaresima nei nostri Paesi occidentali, nei
quali molti mangiano fin troppo (anche se alcuni non abbastanza)! Il problema si pone oggi su
scala planetaria. Giovanni Crisostomo ricordava che "la bontà, la compassione, la misericordia e
l'amore esprimono contemporaneamente sia la natura di Dio che il suo operare", e che il povero e un
altro Cristo. Possa un digiuno, condotto con intelligenza, liberare le nostre intelligenze dagli
idoli dell’economia>>.
Tornare al digiuno, contro la voracità dei consumi
Non si può vivere la quaresima
senza vivere il digiuno. Anzi, la quaresima – come testimoniano ancora i testi
liturgici che i cristiani continuano a pregare in questi quaranta giorni, senza
rendersi conto della schizofrenia fra il loro dire e il loro fare – è il tempo
del digiuno per eccellenza.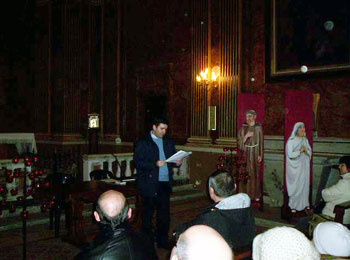
Ma sappiamo tutti che,
purtroppo, il digiuno ha perso significato per i cristiani d’occidente – a
differenza di quanto avviene ancora oggi per le chiese ortodosse e orientali – e
che ormai nessuno crede che il rapporto con il cibo sia un luogo di esperienza
spirituale. Il digiuno dunque appare come un’osservanza dei tempi passati,
quando l’ascesi era ritenuta necessaria per andare in Paradiso e quando,
paradossalmente, la fame era esperienza possibile per la maggioranza della
gente. Tuttavia, ed è un altro paradosso, oggi il digiuno è sovente al centro
dell’attenzione e si tenta di praticarlo per ragioni dietetiche, per motivi
estetici o sportivi. Qualche volta poi appare come mezzo di lotta e di protesta,
con il nome più politico di “sciopero della fame”: digiuno ostentato che deve
“apparire”, essere assolutamente notato e messo in risalto dai mass-media, pena
il fallimento dello scopo prefissato; una forma di digiuno, questa, che è
l’esatto contrario del digiuno cristiano che, secondo il comando di Gesù,
dovrebbe avvenire nel segreto (cf Mt 6.16), senza che nessuno se ne accorga.
La mia generazione, che ha
ancora praticato il digiuno dalla mezzanotte prima della celebrazione
eucaristica, il digiuno alla vigilia delle feste e quello, seppur già attenuato,
della quaresima, - si è adattata in modo acritico e senza resistenza a questa
perdita di uno strumento assolutamente necessario per una vita cristiana matura.
E’ troppo tardi oggi per riprendere questa prassi così profetica, così capace di
resistenza nei confronti del consumismo e dell’egoismo? Convinti che il cuore
intrascendibile di decisioni e atteggiamenti rimane la coscienza, il cuore del
cristiano, crediamo allora necessario riproporre il digiuno.
Conosciamo bene quest’atmosfera
regnante in occidente, dove risuonano messaggi ossessivi che chiedono “di tutto,
di più e subito”, dove i modelli sono tesi a quella voracità che chiamiamo
consumismo e dove regnano “novelli dèi e signori”
 che impongono comportamenti philautistici e narcisisti, maschere di un egoismo che non riconosce l’altro né,
tantomeno, tra gli altri, gli ultimi e i bisognosi. Diciamo la verità: quelle
rare volte che oggi si chiede il digiuno ai cristiani lo si fa nella forma,
minacciata di ipocrisia, di una cena sacrificata a favore degli affamati, oppure
come impegno per la pace. Troppo poco, e comunque il digiuno cristiano, quello
“comandato”” – si, comandato! – da Gesù e dalla chiesa primitiva è altra cosa e,
tra l’altro, non va neppure confuso con il digiuno praticato dai musulmani
durante il mese di ramadan. che impongono comportamenti philautistici e narcisisti, maschere di un egoismo che non riconosce l’altro né,
tantomeno, tra gli altri, gli ultimi e i bisognosi. Diciamo la verità: quelle
rare volte che oggi si chiede il digiuno ai cristiani lo si fa nella forma,
minacciata di ipocrisia, di una cena sacrificata a favore degli affamati, oppure
come impegno per la pace. Troppo poco, e comunque il digiuno cristiano, quello
“comandato”” – si, comandato! – da Gesù e dalla chiesa primitiva è altra cosa e,
tra l’altro, non va neppure confuso con il digiuno praticato dai musulmani
durante il mese di ramadan.
Perché, dunque, il digiuno
cristiano? Va detto che occorre praticarlo per capirlo e coglierne le
motivazioni profonde. Innanzitutto, digiunare significa imprimere una disciplina
all’oralità. I monaci, in particolare, hanno avuto la consapevolezza che il cibo
trascina con sé una dimensione affettiva straordinariamente potente.: anoressia
e bulimia sono gli indici di turbamenti affettivi che si ripercuotono
nell’alimentazione. Ecco perché il comportamento alimentare nell’uomo riceve un
surplus di senso: non dipende solo da bisogni fisiologici, ma appartiene al
registro dell’affettività e del desiderio. L’oralità, allora, richiede una
disciplina per passare dal bisogno al desiderio, dal consumo all’atteggiamento
eucaristico del ringraziamento, dalla necessità individuale alla comunione. E
qui l’eucarestia mostra il suo magistero come esercizio ed esperienza di
comunione, di condivisione. Ecco la ragione del digiuno prima dell’eucarestia:
non una mortificazione per essere degni, non una penitenza meritorio, ma una
dialettica digiuno-eucarestia, una disciplina del desiderio per discernere ciò
che è veramente necessario per vivere, oltre il pane. Con il digiuno si tratta
di dominare il vettore del consumo per promuovere il vettore della comunione.
Ma il digiuno è necessario
anche per conoscere da cosa siamo abitati: chi prova a digiunare sa che, a
partire dal secondo o terzo giorno, vede sorgere in lui collera, cattivo umore,
bisogni prepotenti. Tutte occasioni per porsi domande essenziali; chi sono io,
in realtà? Quali sono i miei desideri più profondi? Da cosa sono interiormente
toccato? Quando sono insoddisfatto e quando invece nella pace? Si, il digiuno
aiuta a scavare in profondità, a conoscersi nella propria intimità, nel segreto
dove Dio vede e dove è trovato (cf Mt 6.6).
Certo, il digiuno sarà anche
opera di penitenza, pratica di solidarietà e di condivisione, ma sarà
soprattutto questo provare se stessi nel rapporto con il cibo per discernere la
nostra vera fame e il nostro autentico rapportarci a Dio e ai fratelli. Nel
digiuno, infatti, la nostra preghiera si fa corporale, si incarna in ciascuno
di noi e il nostro rapporto intellettuale con la realtà si completa in questo
confessare con le fibre del nostro corpo che noi cerchiamo Dio, che desideriamo
la sua presenza per vivere, che oltre al pane abbiamo bisogno della sua parola (cf
Mt 4.4)
Il digiuno non è un fine in sé,
rimane uno strumento privilegiato della vita spirituale, teso anch’esso
all’unico fine della vita cristiana: la comunione con Dio e con gli uomini.
***
Quaresima: una
grande occasione anche per chi non è cristiano
A più riprese,
auspicando un maggiore dialogo e ascolto reciproco tra credenti e non credenti,
ho avuto modo di sottolineare l’importanza che i cristiani riuscissero a
esprimere le proprie istanze etiche in termini e prospettive antropologiche e
non solo dogmatiche, Non si tratta di tacere i principi che si ritengono
essenziali e nemmeno di ridurre il cristianesimo a una forma di umanesimo quanto
di adeguare il proprio linguaggio affinché quanto si afferma e si sostiene possa
essere correttamente recepito - che non significa automaticamente accettato o
condiviso – dai propri interlocutori. Sovente invece sembra di assistere non a
un dialogo tra sordi ma a una babele di linguaggi, fonte di incomprensioni che
hanno come vittime gli interlocutori stessi e la sana convivenza civile.
Penso, per esempio, a come
l’evolversi della nostra società abbia finito per relegare nelle “sacrestie” un
tempo forte come la quaresima, di cui i non cristiani hanno finito per cogliere
solo una mesta contrapposizione al carnevale, mentre i cristiani stessi sovente
ne hanno smarrito la pratica, e, conseguentemente, la ricchezza umana e
spirituale. Salvo poi riscoprirne, cristiani e non, alcuni elementi, prendendoli
a prestito da altre religioni o sistemi etici e filosofici. In verità sarebbe
tempo che i credenti riprendessero una “pratica profetica” della quaresima,
perché anche in questo sta la “differenza cristiana” che attraverso il
comportamento appare visibile, capace di narrare la speranza che abita il cuore
dei credenti. Non si tratta di tornare a vivere in modo legalistico e meritorio
delle “osservanze” ma di praticare, di mettere in atto alcune opzioni che,
proprio in quanto sono di aiuto alla vita cristiana, sono anche una prassi in
vista di una maggiore qualità di vita umana e di convivenza sociale. Mi
riferisco in particolare a due ambiti che si possono ricondurre ad altrettante
istanze “classiche” dell’ascesi cristiana: il silenzio e il digiuno.
Del primo ho già parlato
recentemente su queste stesse colonne ma vorrei sottolinearne anche la valenza
come spazio e tempo per ascoltare, pensare e leggere. Pratiche quotidiane rese
ardue da ritmi e abitudini dettate da velocità, immagini e rumori eppure
indispensabili perché la nostra vita non sia da noi ”subita” ma divenga
l’espressione di una nostra ricerca, non sia un accadimento ma un “atto” da noi
compiuto. Il nostro udito è quasi incessantemente sottoposto a intenso lavoro ma
questo ha diminuito la nostra capacità di affinarlo e di cogliere tra parole e
rumori confusi un senso, un’indicazione di vita, il messaggio di una persona che
va “ascoltata”, cioè accolta e ospitata nella propria dimora interiore.
In questi ultimi anni, infatti,
il deserto della barbarie ha guadagnato sempre più terreno nelle nostre società
e minaccia ormai ogni ambiente. Ci sono alcuni cristiani che sovente si mostrano
arroganti, assumendo uno stile di difesa e di attacco non conforme alla loro
fede; altri uomini, che hanno una figura pubblica nella polis, sembrano non
sapere quello che dicono e quello che fanno, comportandosi con aggressività e
violenza tali da minacciare seriamente di distruggere la stessa democrazia: tra
avversari politici ci sono disprezzo, calunnia, offesa, dilatati dai mass-media
al punto che la gente comune si sente autorizzata ad emularli persino in
famiglia o tra conviventi; c’è una barbarie che avanza quando si vedono gruppi
di cittadini assumere comportamenti che manifestano più sete di vendetta che
voglia di giustizia.
Si, dobbiamo trovare il tempo
per fermarci a riflettere su che tipo di società stiamo costruendo giorno dopo
giorno: una convivenza dialettica e pacifica oppure una giungla in cui vivere
egoisticamente senza gli altri o addirittura contro gli altri? Abbiamo bisogno
di un tempo per pensare, riflettere, rielaborare quanto ascoltiamo, così da
poterlo assumere, contraddire, approfondire, in una parola “farlo nostro”. E’ il
grande dono che il pensare ci riserva: arricchirci di quanto proviene da una
alterità e rendere così la nostra identità più solida e variegata al contempo.
In questo senso anche la lettura è una modalità di ascolto, un modo per
addentrarsi in un mondo altro eppur conoscibile e riconoscibile. Così annotava a
proposito del leggere uno scrittore non certo da sacrestia, Italo Calvino:
“Leggere vuol dire spogliarsi di intenzione e di ogni partito preso per essere
pronti a cogliere una voce che si fa sentire quando meno ci si aspetta, una voce
che viene non si da dove, da qualche parte al di là del libro, al di là
dell’autore, al di là delle convenzioni della scrittura. Dal non detto, da
quello che il mondo non ha ancora detto di sé e non ha ancora le parole per
dire”. Perché allora non prenderci quella quarantina di giorni che precedono la
Pasqua come occasione privilegiata per tornare, o andare, ad alcuni testi che
non si appiattiscono sul contingente?
L’altro ambito “quaresimale”
che può dire qualcosa anche all’uomo post-cristiano contemporaneo è il digiuno:
non penso tanto a una drastica riduzione dei cibi e nemmeno alle valenze
salutistiche o “politiche” che hanno trasformato questa pratica propria a tutte
le religioni in una corsa alla dieta o in uno strumento di lotta come lo
sciopero della fame. Penso invece all’aiuto che può venire, a livello
individuale come sociale, da una maggiore sobrietà nel consumo degli alimenti e
dei beni in genere: un’attenzione a ciò che è veramente essenziale per la nostra
vita, una consapevolezza che noi siamo ciò che mangiamo, che quanoi ci nutre ci
plasma anche; e, accanto a questo, uno stimolo alla condivisione e alla
solidarietà, un più sensato uso delle risorse comuni, una diversa comprensione
dei fenomeni economici e sociali che spingono milioni di persone a muoversi
dalla fame verso il pane.
Non è un caso che già i profeti
biblici, lungi dal relegare le pratiche di penitenza nella sfera della devozione
privata, fossero esigenti nel porre il digiuno in stretta relazione con la
giustizia e la condivisione. Così, per esempio, ammoniva Isaia prestando voce al
Signore: “Non è piuttosto questo il digiuno che io voglio: sciogliere le catene
inique, togliere i legami del giogo, rimandare liberi gli oppressi e spezzare
ogni giogo? Non consiste forse nel dividere il pane con l’affamato,
nell’introdurre in casa i miseri, senza tetto, nel vestire uno che vedi nudo,
senza distogliere gli occhi da quelli della tua carne?” Si, i cristiani hanno
ancora oggi un messaggio che parla a ogni uomo, indipendentemente dalle sue
convinzioni religiose, perché è un messaggio che ha a che fare con i diritti
inalienabili di ogni essere umano, con una vita degna di tale nome.
A cura di Padre Pierpaolo
Ottone – crm (chierici regolari minori) |
